Il “The end” nel cinema

Il film si deve sempre chiudere con un finale. Mi ha colpito come la cinematografia tratti il tema del funerale, del no-happy end. In primis, c’è un film di Akira Kurosawa, Sogni, che rappresenta perfettamente la mia lettura del momento del commiato. Il film va visto tutto, e per fortuna su Youtube, manca la scena completa, così chi volesse vederlo può cercarlo in biblioteca, o comprarlo. In questo spezzone manca il finale che commenta l’allegro corteo funebre: gli amici del morto non piangono la persona persa, ma festeggiano la vita che ha vissuto. Una visione della perdita che rinuncia alla tristezza per godere di gioia.
Di spirito affine, in Occidente, c’è il funerale di Perozzi in Amici miei di Mario Monicelli, suicida figlio del suicida Tomaso, a proposito della cui scelta di non vita il regista commentò:
Ho capito il suo gesto. Era stato tagliato fuori ingiustamente dal suo lavoro, anche a guerra finita, e sentiva di non avere più niente da fare qua. La vita non è sempre degna di essere vissuta; se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena. Il cadavere di mio padre l’ho trovato io. Verso le sei del mattino ho sentito un colpo di rivoltella, mi sono alzato e ho forzato la porta del bagno. Tra l’altro un bagno molto modesto.
Ma poi è proprio obbligatorio essere qualcuno?
Elio Petri e il tema della morte
Un regista che in molti dei suoi film mette dentro un funerale è Elio Petri. Già nel primo lungometraggio I giorni contati, capolavoro negletto della storia del cinema, in una scena centrale il protagonista Cesare (Salvo Randone) va al mare. Intrattenutosi a chiacchierare con un bambino sulla spiaggia, viene a sapere che un uomo è affogato.
Subito si precipita per vedere se si tratta di qualcuno dei suoi amici, ma quello creduto affogato è proprio Cesare: i suoi amici, non trovandolo più, credevano fosse morto. L’episodio si conclude con la frase di un curioso: “Quello che doveva mori’ manco lo sapeva”. In modo del tutto simile, in Accattone di PierPaolo Pasolini, Vittorio in sogno assiste al proprio funerale.
C’è poi quello dei notabili in A ciascuno il suo, in cui gli astanti al funerale dei due morti disegnano il ritratto dei personaggi protagonisti.
La classe operaia va in paradiso, il funerale lo celebra già nel titolo. Nella seconda visita al Militina (ancora Randone), l’ex-compagno rivela a Lulù (Gianmaria Volontè): “Se vuoi diventare matto, devi tornare in fabbrica” e Lulù ci torna, dopo un infortunio che lo aveva fatto ribellare al sistema. Ora è impiegato, coi compagni rivoltosi, alla catena di montaggio. Racconta loro un suo sogno – probabilmente suscitato da quell’ultimo incontro al manicomio, in cui Militina, prende a colpire con la testa il muro del cortile, ripetendo “Giù il muro” -, ma nessuno lo sente a causa del rumore dei macchinari. Le facce degli operai si deformano, diventano maschere espressioniste dell’alienazione, senza via di ritorno, cui sono destinati, della incomunicabilità che non permette a questi uomini bestie di parlare tra loro, malgrado siano vicini l’uno all’altro.
Nel chiasso Lulù cerca di raccontare di aver sognato un muro, ma gli operai lo interrompono: “Eh?”; “Sognavi cosa?”; “Che dicono? Non capisco, non sento”; “Cosa hai sognato?”; “Come?”; Lulù: “Ero lì che sognavo un muro… Ero… Sono morto, no”, con un significativo spostamento del tempo verbale dal passato al presente; tutti strillano il nome del Militina, che alla fine è quello che viene creduto defunto, ma Massa rivendica a gran voce la propria morte.
In Todo modo, Petri ci offre la sua personalissima lettura dell’inferno: un eremo dalle sembianze di un garage del sottosuolo è abitato da un’ambigua guida «spirituale» (Marcello Mastroianni) che ha tutto l’aspetto del diavolo di Rutilio Manetti, da demoniache materializzazioni di opere religiose di Salvador Dalì, da epidermidi bruciate di Alberto Burri e dai corpi dannati dei notabili che governano il paese e che qui terminano la loro esistenza ammucchiati l’uno sopra l’altro come i crudeli sopravvissuti de La zattera della Medusa di Théodore Géricault.
Nel film La proprietà non è più un furto, il monologo di Paco l’Argentino (Gigi Proietti), che si svolge davanti alla folla di astanti riunitasi al Verano, per la commemorazione funebre di Albertone, perde l’enfatico annullamento ambientale presente per gli altri personaggi – e quindi la splendida fotografia di Luigi Kuveiller capace di mettere in rilievo le luci e le ombre, esteriori ed interiori del declamatore del monologo – a favore di un lungo piano sequenza che si stringe sul volto di Proietti.
La telecamera montata sul carro funebre permette una ripresa distorta, che sembra riportare il punto di vista del defunto, quasi cavalcasse la bara in mezzo alla folla, con un richiamo ai Funerali di Oskar Panizza di George Grosz. Durante il discorso di Paco, essa si muove e indaga i volti dei ladri raccoltisi a omaggiare Albertone: uomini e donne si deformano sotto la lente dell’obiettivo in un’espressività esasperata che mostra la corruzione interiore di ciascuno di loro. L’identificazione non è soltanto tra il monologante e il suo pubblico, tutto nascosto dietro occhiali da sole, che, come quello di Grosz, rappresenta il male, ma è estesa all’intera umanità, accomunata dall’appropriazione indebita:
Io, Paco l’Argentino, voglio tesse’ l’elogio del ladro. De’ tutti noi, de’ tutti voi. Amici, compagni, colleghi e rivali… Ma che sarebbe er monno senza de’ noi? Pensatece. Quanti de’ questi magnafregna che se freggiano der nome di onesti andrebbero a fini’ sul lastrico? Quanti?Famo li conti na’ bona vorta. Li volemo fa’?
Li fabbri. Li fabbri che farebbero senza i ladri?E le fabbriche de’ serrature? E le fabbriche de’ saracinesche? E tutti l’impiegati de’ banca, e i guardiani notturni, e i poliziotti, e i carabinieri? E quelli che costruiscono porte, finestre, l’inventori e i costruttori di antifurto, sempre più perfezionati? E i portieri, e l’avvocati, e i giudici, e i secondini, e i direttori di penitenziari, e le guardie notturne, e li assicuratori [cogliendo il suggerimento di un astante], e i cani poliziotto che farebbero tutti questi senza de’ noi? Pensatece amici, pensatece. Quanta gente rimarrebbe a spasso se tutti noi, tutti insieme, per vendetta contro questa società ingrata, tutti quanti insieme, un ber giorno, allo stesso momento, decidessimo tutti… De smette’ da ruba’. L’economia nazionale se n’andrebbe a rotoli. È pe’ questo che io qui dico: giù er cappello davanti a Albertone, eroe del lavoro. Dico de’ più: santo. È a noi che la società deve l’ordine costituito e l’equilibrio sociale perché noi rubbanno allo scoperto, coprimo e giustificamo i ladri che operano coperti dalla legalità. Onore a Albertone e a tutta la ladreria.
Nelle Buone notizie, ultimo film del regista romano, al funerale di Gualtiero (Paolo Bonacelli), l’uomo senza nome protagonista, interpretato da Giancarlo Giannini, vede Ada ridere tutto il tempo e correre tra le tombe come una pazza e sua moglie Fedora (Angela Molina) piangere disperatamente.
L’anonimo scioccato chiede a Fedora spiegazioni per quel cordoglio inusitato nei confronti di un estraneo. Il personaggio interpretato dall’icona surrealista Molina di Quell’oscuro oggetto del desiderio diretto da Luis Buñuel, confessa di aver conosciuto Gualtiero durante quattro supplenze nella scuola dove il professore era di ruolo, di aver ceduto al desiderio. A sua discolpa Fedora spiega al marito: “Era un po’ come stare con un altro te, era un transfert! […] Gualtiero mi ha fatto capire delle cose di te che io non avrei mai capito, ma mai, mai. E poi lui in fondo vedeva in me… vedeva te”.
L’identificazione dei due vecchi compagni è compiuta, quando all’uomo senza nome non rimane che rassicurare Fedora sul figlio che sta aspettando: “Lo chiameremo Gualtiero”.
Questo lieto fine al tramonto, calante tra cumuli di pattumiera, viene interrotto da un’appendice che lo guasta: l’uomo senza nome trova sulla scrivania del suo ufficio una busta da parte di Gualtiero Milano che contiene un’altra busta con la scritta «DA NON APRIRE». Evacuato dal luogo di lavoro per il rischio di una bomba, al Parco del Turismo, tra le grida di una donna implorante aiuto, apre lo stesso la busta colma di bigliettini con la stessa scritta «DA NON APRIRE».
“L’ultimo messaggio di Gualtiero – scrive Mino Argentieri, nel capitolo “I «grotteschi» di Elio Petri” del volume Il cinema del riflusso. Film e cineasti italiani degli anni ‘70 – racchiude l’assunto del film: non si deve scoperchiare la realtà poiché non c’è spiegazione possibile, tutto è assurdo”.














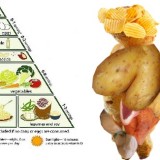


Una risposta
[…] Créditos de imagem: alimentarmente.it […]