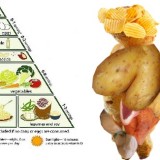The harvest: il racconto di un cattivo raccolto

C’eravamo soltanto io e la mia accompagnatrice a vedere The harvest, un film che sceglie una o meglio più formule registiche. La proiezionista è arrivata a un minuto dalla programmazione, perché i protagonisti del film sono degli invisibili e tali devono restare, oppure probabilmente perché il giorno prima non c’era nessuno e avrà pensato Oggi nevica pure, chi verrà mai a vederlo? Presenti!
La formula di fondo che il regista Andrea Paco Mariani sceglie è il documentario, che registra le condizioni alle quali è costretta la comunità sikh nell’Agro Pontino, dove lavora sotto il caporalato. Il volto del protagonista si vede bene soltanto all’inizio quando in un estremo tentativo di mantenere la dignità il protagonista, un indiano dal turbante arancione, si fa bello spazzolando la lunga barba e si fascia la testa, un vero e proprio tutorial su come si indossa il foulard tipico. Poi il suo volto rimane per la maggior parte del tempo rivolto verso la terra che zappa per tutto il giorno sotto un sole nemico. Umilmente, secondo l’etimo latino, che spinge in basso. Si zappa anche per 14/16 ore di fila, a meno che non si voglia cedere il proprio posto a qualche altro sventurato. Per reggere la fatica della raccolta manuale degli ortaggi, la semina e la piantumazione per 12 ore al giorno filate sotto il sole, e anche gli insulti del padrone, i suoi ricatti, la sua arroganza, la ricompensa che tale non è, i più vessati vanno avanti assumendo metanfetamine, contravvenendo ai dettami del sikhismo, ma stando bene attento a non entrare in contatto con la bottiglia. Va meglio alla protagonista femminile del film, che fa la mediatrice culturale, e che ha superato tutte le insidie dell’emigrazione attraverso suo padre che, non appena arrivato in Italia, ha “dimorato” a lungo sulle panchine della capitale.
Con questo freddo, sotto i portici vicino a casa mia, un senzatetto dorme tutte le sere al gelo di questo febbraio. Ho chiamato e diffuso i numeri di assistenza per l’emergenza freddo, ma non mi risponde nessuno. Lo cerco preoccupata tutte le sere. Un po’ di anni fa, con la croce rossa di Sesto San Giovanni, ho fatto il giro con l’unità di strada per portare beni di prima necessità e tazze di tè bollente ai senza dimora di Sesto e Milano. È stata una delle esperienze che più mi hanno segnata. Il primo incontro è stato con un giovanissimo alla prima sua notte all’addiaccio. Non c’è stato verso di convincerlo a tornare a casa, ma già si lamentava per aver preso delle verruche sulle dita. Invece, ricordo che l’ultima persona che ho incontrato era un ragazzo molto giovane che rivendicava animosamente i suoi studi di Filosofia. Quando gli abbiamo proposto di venire con noi che lo avremmo portato al dormitorio, mi ha risposto: “ vuoi mettere con il dormire sotto le stelle?”. Il suo compagno di giaciglio aveva le gambe devastate dai buchi delle siringhe che si erano infettati per essere marciti in maleodoranti e dolorose pustole. Una ragazza non voleva né vestiti, né cibi e bevande, soltanto dei trucchi perché doveva prostituirsi con gli altri clochard per guadagnare pochi euro, elemosinati dai suoi “compagni”. C’era un freddo pungente e il giorno dopo avevo la febbre alta, mentre leggevo sul giornale che un senza dimora era deceduto nella notte. Chissà se lo avevamo incontrato?
Ma la ragazza di The harvest è ormai completamente integrata perché conosce l’italiano che parla perfettamente con una evidente flessione romana. Conoscere la lingua, spiega ai suoi studenti, permette di non farsi fregare dagli altri, dai caporali, dai padroni, da scorrettezze contrattuali.
Oltre alla formula documentaria, il film sviluppa la formula del musical bollywoodiano a far uscire la gioia di vivere nonostante tutto: in abiti coloratissimi tradizionali, che ho desiderato per tutta la durata del film, hanno luogo coreografie danzanti che si materializzano nei momenti in cui l’uomo dal turbante arancione, ha tregua dal lavoro. Finché scende la sera foscoliana e si torna a casa (si torna?).